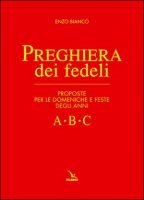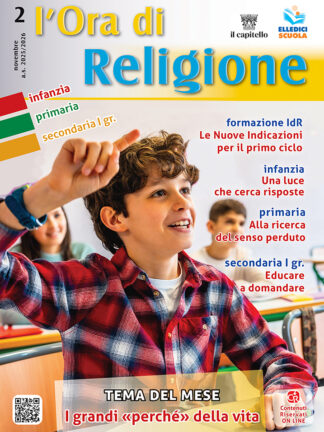Pellegrini sulla terra verso la patria comune
Ci si potrebbe domandare: per chi si celebra la festa di oggi? per quelli che siamo soliti chiamare i «santi» del paradiso, facendone memoria nel calendario, contemplandone le immagini, pregandoli perché ci ottengano le «grazie»? o per quelli che, con un linguaggio a noi insolito ma familiare alla prima comunità cristiana, si chiamavano allora correntemente i «santi», a cui Paolo indirizzava le sue lettere, a cui Pietro si rivolgeva come a «nazione santa» (1 Pt 2,9), cioè tutti i membri della Chiesa che continuiamo a chiamare «una, santa, cattolica e apostolica»? In realtà, questo epiteto spetta di pieno diritto solo a Dio, al Padre che tre volte nella preghiera eucaristica, ripetendo l’inno dei serafini, proclamiamo «santo» (Is 6,3); al Figlio: «Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo»; allo Spirito Santo, disceso su Maria per operare in lei il mistero dell’incarnazione di colui che «sarà santo e chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,35). Questa santità unica e perfettissima è comunicata, per pura bontà di Dio, alla Chiesa: «Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cf Eb 5,1-5), fece del nuovo popolo “un regno e dei sacerdoti per Dio, suo Padre” (Ap 1,6; cf 5,9-10). Infatti, per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati a formare una dimora spirituale e un sacerdozio santo» (Lumen gentium, 10).
«L’assemblea festosa dei nostri fratelli»
È questa che il prefazio c’invita a contemplare nella «città del cielo, la santa Gerusalemme che è nostra madre», mentre «glorifica in eterno» il nome di Dio. Nell’Apocalisse, con il linguaggio caratteristico di questo libro, si parla d’un numero simbolico, 144.000, di «una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua». (Dunque nessuna paura per i negri d’America divenuti cristiani, trattati per secoli in modo disumano anche da tanti fratelli di fede, di diventare bianchi quando andranno in paradiso, come diceva più d’un secolo fa uno di loro, protestando che piuttosto preferiva restare nero e andare all’inferno. E nessuna paura che debbano trasferirsi in cielo quelle discriminazioni sociali che continuano anche fra i cristiani bianchi…). L’Apocalisse ci presenta i santi «in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani», simbolo di vittoria sul peccato, mentre lodano Dio e l’Agnello, Cristo morto per noi. Sono arrivati alla felicità eterna attraverso la grande tribolazione, partecipando alla passione di Cristo. Come apprendiamo da Giovanni nella 2a lettura, Dio s’è manifestato a loro ed essi ora lo vedono «così come egli è». Oggi li ricordiamo festanti, «lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa, che ci hai dato come amici e modelli di vita» (prefazio). Uniti a loro nella comunione dei santi, «è sommamente giusto che amiamo questi amici e coeredi di Gesù Cristo e anche nostri fratelli e insigni benefattori, e che per essi rendiamo le dovute grazie a Dio, che “rivolgiamo loro supplici preghiere e ricorriamo alle loro preghiere e al loro potente aiuto per impetrare grazie da Dio mediante il figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro, il quale solo è il nostro Redentore e Salvatore”». Infatti, continua il Concilio, «ogni nostra autentica attestazione di amore fatta ai santi per sua natura tende e termina a Cristo che è la “corona di tutti i santi”, e per lui a Dio, che è mirabile nei suoi santi e in essi è glorificato» (Lumen gentium, 50). La festa odierna ci richiama alla vera «devozione» ai santi, che deve sempre condurci a Cristo e stimolarci a seguire il loro esempio.
Le beatitudini
Gli esempi che ci danno i santi trovano il loro compendio nelle beatitudini. Abbiamo contemplato «la città del cielo» dove essi lodano nel gaudio pieno ed eterno il Signore. Gesù, all’inizio del discorso della montagna, ci indica la via per arrivarci un giorno anche noi. Ci insegna (questo è più chiaro nella formulazione del Vangelo di Luca) che la condizione di povertà, di umiltà, di sofferenza, è motivo di predilezione da parte di Dio. Ci chiama – e Dio sa se oggi ce n’è bisogno! – a giudicare secondo un metro di valori diametralmente opposti alla mentalità dominante, che proclama felici quelli che dispongono del denaro e del potere, che possono contare sul successo e soddisfare senza ritegno tutti gli istinti che spingono alla ricerca del piacere. Nella presentazione di Matteo, che riflette la catechesi maturata nella comunità, in piena fedeltà all’insegnamento del Maestro, si insiste sulle disposizioni interiori con cui il discepolo è invitato a vivere la sua condizione di povertà, di umiltà, di sofferenza. Si ricorda al cristiano che la vera beatitudine non consiste nel chiudersi in se stesso ma nell’aprirsi agli altri con la partecipazione alle loro sofferenze e con l’aiuto fraterno, nel farsi «operatori di pace». È una beatitudine vera quella che Gesù promette, già in questa vita, pur fra le persecuzioni che attendono chi vuole seguirlo fino in fondo, ma la «ricompensa» piena, che sarà «grande», avrà luogo «nei cieli».
Amore e speranza
È dunque con una parola di speranza che si conclude il messaggio delle beatitudini. Quel-la speranza in Dio a cui c’invita s. Giovanni, speranza che ci purifica e ci fa rassomigliare a Dio, purezza ineffabile e infinita. Quella speranza, ci dice ancora il prefazio, nella quale, «pellegrini sulla terra, affrettiamo… il nostro cammino verso la patria comune». Troppe volte, nel linguaggio di tutti i giorni, la parola «speranza» dà un suono falso, come d’una parola che si ripete senza convinzione quando non si sa dire altro («Coraggio, fatti coraggio», si continua a dire a un malato inguaribile), o come un’illusione a cui si tenta di aggrapparsi in qualche modo: «La speme, ultima dea». Ma s. Giovanni, prima di parlarci di speranza, ci ha invitati a un atto di fede nell’amore che Dio ha per noi: «Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!». È qui la parola definitiva del Vangelo: l’amore, gratuito e preveniente di Dio che ha voluto farci suoi figli. I santi che sono nella felicità del cielo e quelli che camminano accanto a noi sulla terra (ce ne sono, anche ora, ma è difficile riconoscerli!) sono diversi per razza, lingua, condizione sociale, lineamenti fisici e spirituali, per il posto che occupano nella Chiesa e nella società: ma c’è una cosa che tutti li accomuna (anche se si manifesta a sua volta in modo diverso), perché se non ci fosse non sarebbero santi: l’amore. Tutti possono ripetere con s. Giovanni: «Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi. Dio è amore» (1 Gv 4,16). Tutti ci esortano a fare quello che essi hanno fatto: «Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri» (4,11); «Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse: “Io amo Dio”, e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello» (4,19-21). Non pochi tra i santi hanno praticato alla lettera il monito dell’apostolo: «Da questo abbiamo conosciuto l’amore: egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli». Tutti, ciascuno nella propria condizione, hanno fatto ciò che segue subito dopo: «Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità» (3,16-18). Per l’intercessione dei santi che hanno amato, preghiamo: «O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi Santi, fa’ che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore» (preghiera dopo la comunione).
(tratto da: M. Gobbin, Omelie per un anno – vol. 2, anno C, tempo ordinario – Elledici 2003)